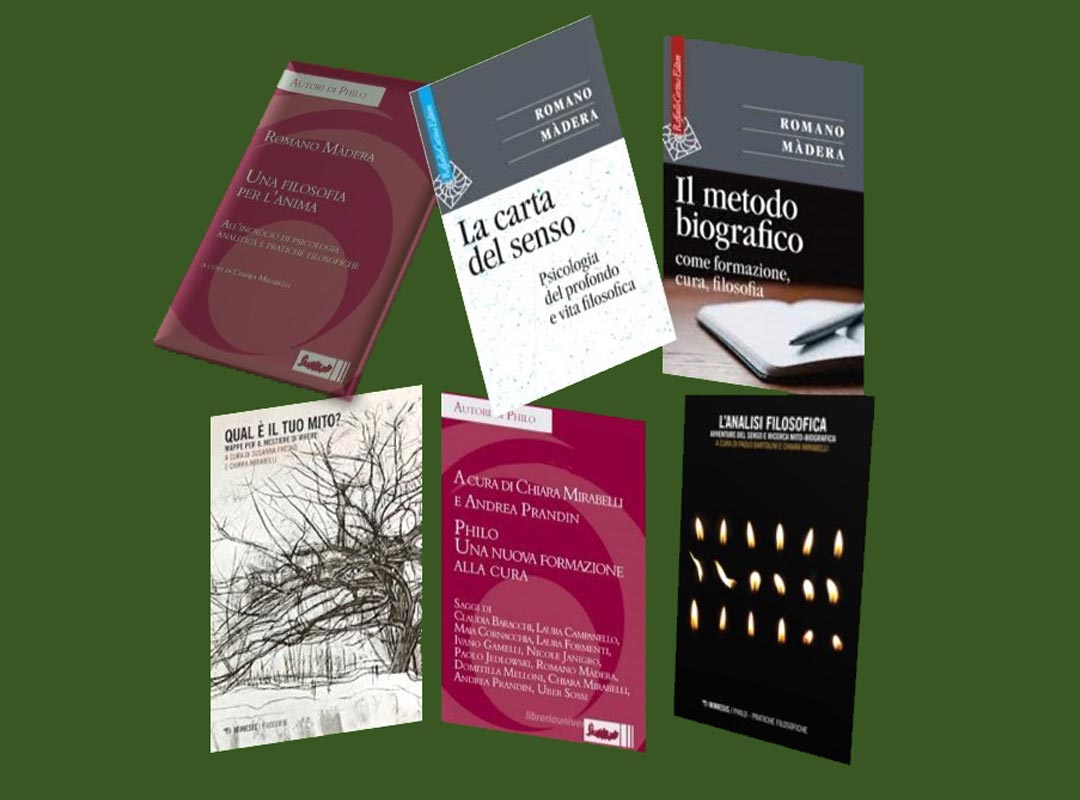 Un vero filosofo – con il che non mi riferisco a un professore di filosofia, il quale per definitionem non è filosofo, visto che si limita a costruire discorsi e non vive mai il proprio pensiero – è colui che trae conclusioni valide per la propria vita: non si tratta di semplici chiacchiere. Egli vive la propria verità, non si riferisce a una sequela di parole, ma a un particolare modello di vita, e anche se non riesce a viverlo fino in fondo, vi si riferisce e vi si approssima.
Un vero filosofo – con il che non mi riferisco a un professore di filosofia, il quale per definitionem non è filosofo, visto che si limita a costruire discorsi e non vive mai il proprio pensiero – è colui che trae conclusioni valide per la propria vita: non si tratta di semplici chiacchiere. Egli vive la propria verità, non si riferisce a una sequela di parole, ma a un particolare modello di vita, e anche se non riesce a viverlo fino in fondo, vi si riferisce e vi si approssima.
Carl Gustav Jung
Trasformare il semplice vivere, la vita che ci viene consegnata e che conduciamo con inerzia, in ciò che è stata chiamata esperienza. Esperienza che forma il primo livello, quello più umile, della conoscenza «delle cose della vita» e senza la quale nessun antico avrebbe osato chiamarsi filosofo.
María Zambrano
Questa è la lezione della filosofia antica: un invito per ogni uomo a trasformare se stesso. La filosofia è conversione, trasformazione della maniera di essere e del modo di vivere, ricerca della saggezza.
Pierre Hadot
L’analisi biografica a orientamento filosofico (Abof) è una relazione di cura nel senso filosofico originario di “terapeutica” del vivere e del vivere-con.
Rivisitando profondamente i campi della filosofia e delle psicologie del profondo l’Abof crea una nuova area di studio e di pratiche di cura esistenziale che attiene alla ricerca di senso per gli individui e per i gruppi che desiderano esplorare la loro vicenda biografica anche al di fuori del perimetro della clinica.
Il metodo analitico-biografico riconosce ogni singola biografia come intessuta da un vasta trama di relazioni (materiali, storiche, simboliche, culturali, sociali) che la compongono e alle quali contribuisce a sua volta a dare forma. È volto altresì ad accompagnare gli individui nella ricerca di un senso che sappia orientare l’esistenza, reggere di fronte alle prove della vita in momenti difficili e facilitarne la piena espressione in un’ottica “individuativa”.
Quattro sono i punti cardinali che possono aiutare la comprensione delle coordinate dell’analisi biografica a orientamento filosofico:
1) il binomio “espressione e riconoscimento”, per cui il soggetto matura solo se libero di esprimersi in uno spazio relazionale accogliente e rispettoso, che fornisca il riconoscimento necessario per consolidare un sano senso di sé;
2) l’integrazione progressiva dei nostri “doppi impresentabili” (aspetti temuti, poco contattati e non accettati di sé) con graduale abbandono delle quotidiane “maschere di carattere” indossate per conformarsi alle aspettative sociali dominanti;
3) la “simbologica” come convivenza creativa tra pensiero indirizzato, logico e discorsivo, da un lato, e pensiero fantasticante, immaginativo e simbolico, dall’altro. Invece di contrapporre queste dimensioni dell’umano, la simbologica ricuce la scissione e nella differenza apprezza il contributo di entrambe le forme di pensiero per una ricerca integrata di senso;
4) l’esercizio delle trascendenze antiche e nuove, finalizzato al superamento della centratura autocompulsiva e dell’egoismo, con relativa ricollocazione del senso di sé all’interno di una percezione più vasta delle relazioni tra i viventi e dei legami che li connettono affidandoli a una comunanza di destino ormai planetaria..
Rispetto al tema della sofferenza esistenziale, l’Abof considera i momenti critici della vita come passaggi ineludibili, cogliendo nel concetto di “crisi di presenza” coniato da Ernesto de Martino uno spunto prezioso per descrivere il rischio, comune a tutti gli umani, di perdere orientamento quando le condizioni del divenire storico-sociale minacciano l’equilibrio esistenziale. L’Abof, assumendo una prospettiva sul disagio che è anche antropologica e filosofica, si rivolge soprattutto a chi vuole proteggere e potenziare la propria presenza fronteggiando le difficoltà della vita che impongono un ripensamento della propria posizione etica ed esistenziale. Le dinamiche che concorrono a generare tali difficoltà sono sistemiche e irriducibili alla sola sfera psicologica: mettono piuttosto in gioco l’interezza del soggetto e la sua capacità di reperire un senso vitale nel flusso molteplice dell’esperienza soggettiva e interpersonale.
Per approfondimenti:
- Dialoghi tra filosofia e psicoanalisi, 2021, intervista a Romano Màderaa cura di Davide D’Alessandro (https://www.youtube.com/watch?v=sDAKD1KRcpM)
- Che cosa è l’analisi biografica a orientamento filosofico?di Romano Màdera (https://www.scuolaphilo.it/download/madera-abof.pdf)
- Dodici domande su psicoanalisi e filosofia (https://sabof.it/PDF/2018-Madera-dodicidomandepsicoanalisifilosofia.pdf) di Romano Màdera
- Intervista sull’Analisi Biografica a Orientamento Filosofico a Moreno Montanari (https://www.officinafilosofica.it/blog/intervista-a-moreno-montanari/)
- L’analisi filosofica. Avventure del senso e ricerca mito-biografica, a cura di P. Bartolini e C. Mirabelli, Mimesis, Milano-Udine, 2019
